Televisione by Carlo Freccero
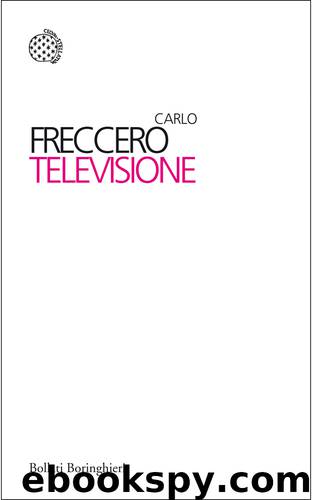
autore:Carlo Freccero
La lingua: ita
Format: mobi, epub
editore: Bollati Boringhieri
pubblicato: 2013-01-07T23:00:00+00:00
5. Televisione e postmodernità
Dalla modernità alla postmodernità
La frattura epistemologica degli anni ottanta si esprime anche e soprattutto con un radicale mutamento di mentalità.
La modernità è figlia dell’Illuminismo, della fiducia nella ragione e nel suo rigore logico. Come tale è figlia a sua volta della pagina scritta, che permette di costruire argomentazioni complesse e articolate. La modernità crede nel progresso e nella capacità umana di gestirlo. È legata alla Rivoluzione francese e alla sua idea di cambiamento e di razionalizzazione della storia.
La postmodernità è l’uscita da questa visione, tutto sommato ottimistica della realtà, secondo cui non solo la realtà è conoscibile, ma è anche modificabile dall’uomo. Per la modernità esistono una verità e un progresso, e i nostri sforzi conoscitivi si rivolgono al passato, per costruire il futuro. Questa prospettiva si sgretola con il passaggio alla postmodernità.
L’organizzazione del sapere nella società postmoderna è stata analizzata da Lyotard in La condizione postmoderna, un libro che ha avuto grande influenza nel dibattito dei primi anni ottanta.
Semplificando al massimo possiamo considerare «postmoderno» l’incredulità nei confronti delle metanarrazioni. Si tratta indubbiamente di un effetto del progresso scientifico, il quale tuttavia presuppone a sua volta l’incredulità. Al disuso del dispositivo metanarrativo di legittimazione corrisponde in particolare la crisi della filosofia metafisica, e quella dell’istituzione universitaria che da essa dipende. Che statuto può avere il sapere in una società in cui si sono ormai esauriti i valori progressisti della modernità e il suo progetto di emancipazione? Dove può risiedere la legittimità, dopo la fine delle metanarrazioni? Il criterio di operatività tecnologico non è pertinente per giudicare del vero e del giusto.
Il sapere è sempre stato considerato un valore. Illuminismo e marxismo hanno visto nel sapere un veicolo di emancipazione, l’idealismo una manifestazione dello Spirito. La società postmoderna trasforma il sapere in un bene di consumo e di scambio. La crisi delle grandi narrazioni, cioè dei grandi sistemi filosofici, il crollo della metafisica, hanno sbriciolato il sapere in una serie di saperi minori, di tecniche che passano attraverso gli strumenti predisposti dalla tecnologia: video e computer, calcolatrici e macchine per tradurre.
Le moderne tecnologie operano sul sapere semplificazioni o mutazioni, a seconda del funzionamento degli strumenti. Tutto ciò che non è riducibile a una logica binaria e, quindi, tutti i dati che non possono essere inseriti in un computer, sono costretti all’estinzione, anche se così si giunge a una progressiva semplificazione del sapere.
II pensiero si frantuma in una miriade di tecniche locali e parziali. Non siamo più in ambito filosofico e non si tratta più di un problema di verità. Ormai è vero o falso solo ciò che risulta tecnicamente compatibile con i nuovi strumenti del sapere. In fondo Lyotard non esprime un concetto molto diverso dall’equazione di McLuhan «il medium è il messaggio».
Per usare un linguaggio foucaultiano, ogni medium rappresenta un dispositivo atto a elaborare determinate forme di sapere. Perché si dia un sapere, un episteme, è necessaria l’elaborazione di un nuovo discorso.
La società postindustriale è caratterizzata dall’esplosione degli strumenti visivi rispetto al testo letterario. Dallo scritto si passa allo schermo con tutte le conseguenze che ne seguono.
scaricare
Questo sito non memorizza alcun file sul suo server. Abbiamo solo indice e link contenuto fornito da altri siti. Contatta i fornitori di contenuti per rimuovere eventuali contenuti di copyright e inviaci un'email. Cancelleremo immediatamente i collegamenti o il contenuto pertinenti.
| Comunicazione e giornalismo | Diritto |
| Economia, affari e finanza | Educazione |
| Informatica | Ingegneria |
| Medicina e scienze sanitarie | Scienze e matematica |
| Scienze sociali | Umanistica |
Il Barone Rampante by Italo Calvino(2316)
Cecità by José Saramago(2058)
La casa degli spiriti by Allende Isabel(2010)
Kobane Calling (Italian Edition) by Zerocalcare(1896)
Cime tempestose by Emily Brontë(1809)
Ulisse by James Joyce(1683)
Un polpo alla gola by Zerocalcare(1575)
Il Silmarillion by J.R.R. Tolkien(1547)
Novecento by Alessandro Baricco(1537)
Cosmo più servizi by Antonio Riccardi(1510)
25 modi per piantare un chiodo by Enzo Mari(1507)
Lumen by Ben Pastor(1507)
Beren e Lúthien by J. R. R. Tolkien(1447)
Player One by Ernest Cline(1443)
Resto qui by Marco Balzano(1419)
Il gattopardo by Giuseppe Tomasi di Lampedusa(1376)
Love Trotter by Bea Buozzi(1373)
Venezia è Un Pesce by Tiziano Scarpa(1327)
Clean - Tabula rasa by Glenn Cooper(1320)
