Nel nome di Dante by Marco Martinelli
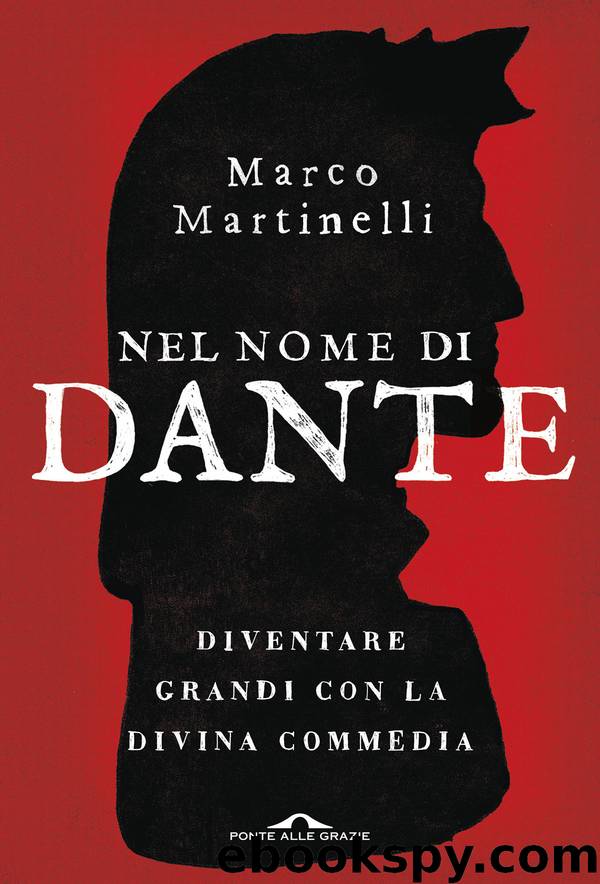
autore:Marco Martinelli [Martinelli, Marco]
La lingua: ita
Format: epub
editore: Ponte alle Grazie
pubblicato: 2019-03-21T21:20:40+00:00
Tu proverai sì come sa di sale
lo pane altrui, e come è duro calle
lo scendere e ’l salir per l’altrui scale.
(Par, XVII, 58-60)
La terzina è famosa, e io l’ho fissata nella memoria da quando me la cantava mio padre: il miracolo dell’arte, di quella musica irresistibile che è la poesia, risiede proprio nel dare forma alla materia delle parole e dei suoni. Quel sale così amaro in bocca, in cui risuona la fatica di scendere e salire dalle scale dei palazzi dei signori, il duro calle, la vergogna di chiedere, di abbassare la testa davanti al potente di turno che mentre lo scruta cerca di ricordare la condanna sul capo di quell’uomo: al rogo, e perché? Perché era un barattiere, ovvero un politico corrotto, uno che si è arricchito a spese dello Stato? Un ladro insomma… e noi dovremmo ospitare a corte un ladro? Meglio non abbassarla, quella testa, meglio tenerla eretta, guardando dritto negli occhi il signore cui si fa richiesta di cibo e accoglienza, nascondendo il desiderio del pane altrui. Come un musicista, il poeta concatena sillabe e suoni sul suo spartito, crea con l’endecasillabo un potente ritmo percussivo, musica e visione al tempo stesso. Il risultato è che noi vediamo tutto quello che la musica di Dante ci fa entrare nell’orecchio.
Eppure, anche in quella condizione così difficile, Dante ritrova la sua vera arma: la scrittura. Per dare voce a quella solitudine, per continuare a fare il suo dovere di intellettuale politico. Perché l’essere lontano dalla patria, infamato, additato come un traditore e un ladro, gli provoca una ferita che va rimarginata. È forse del 1305, o del 1306, la composizione, rimasta incompiuta, di un trattato in latino: il De vulgari eloquentia. È il frutto di chi ha messo la testa fuori dalla Toscana, di chi ha scoperto l’Italia. Il fiorentino comincia a sentirsi cittadino del mondo: «Nos autem, cui mundus est patria». Ovvero: «Noi, che abbiamo per patria il mondo». In questo trattato di linguistica, in questa prima storia della letteratura italiana, Dante si pone uno scopo preciso: dimostrare che il «volgare», la lingua «che si apprende senza norma alcuna imitando la nutrice», è più nobile dell’altra lingua, quella che si impara solo «col tempo e con assiduità di studio», il latino. In altri termini, quelli che useremmo oggi: la lingua viva è più nobile della lingua morta. La prima è in movimento, la seconda è inalterabile come un cadavere. E, dopo aver dimostrato questo, Dante cerca quale sia il volgare più «illustre», tra i tanti che si parlano in Italia: per questo passa a un esame delle varie «parlate» che affollano la penisola, a partire dalla divisione tra la parte destra e la parte sinistra dell’Italia, prendendo come spartiacque l’Appennino. Milanesi e veronesi, romani e fiorentini, ravennati e faentini, e così via; il catalogo delle diverse parlate del popolo si differenzia e si ramifica, e Dante sembra quasi sorpreso dalla ricchezza di lingue che varia da un Comune all’altro, addirittura dalla periferia al centro di una
scaricare
Questo sito non memorizza alcun file sul suo server. Abbiamo solo indice e link contenuto fornito da altri siti. Contatta i fornitori di contenuti per rimuovere eventuali contenuti di copyright e inviaci un'email. Cancelleremo immediatamente i collegamenti o il contenuto pertinenti.
Il colibrì by Sandro Veronesi(3901)
Fahrenheit 451 by Ray Bradbury(3465)
Se questo è un uomo by Primo Levi(3048)
Neverwhere by Neil Gaiman(2987)
Come un respiro by Ferzan Ozpetek(2664)
La casa sull'argine by Daniela Raimondi(2516)
Erewhon by Samuel Butler(2415)
Dieci piccoli indiani by Agatha Christie(2336)
Il Barone Rampante by Italo Calvino(2313)
Lolita by Vladimir Nabokov(2210)
Stardust by Neil Gaiman(2008)
La montagna incantata by Thomas Mann(1901)
Fight Club by Chuck Palahniuk(1699)
Rose, rose by Bill James(1696)
Ulisse by James Joyce(1680)
Lo Hobbit by J.R.R. Tolkien(1665)
Lo Hobbit (illustrato) by John Ronald Reuel Tolkien(1652)
Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald by J. K. Rowling(1600)
Omero, Iliade by Alessandro Baricco(1599)
