Prima lezione di archeologia medievale by Andrea Augenti
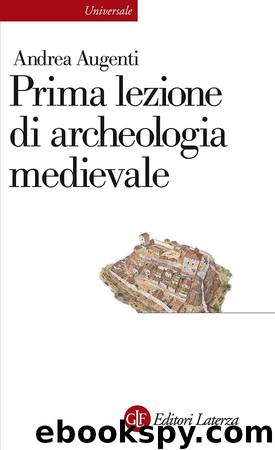
autore:Andrea Augenti
La lingua: ita
Format: epub
Tags: Universale Laterza
editore: Editori Laterza
pubblicato: 2020-07-15T00:00:00+00:00
3.
Archeologia dell’architettura,
archeologia dei monumenti
1. Archeologia dell’architettura: perché nasce una disciplina
A Roma: il Colosseo, ovviamente. E poi il Pantheon, il Teatro di Marcello, i templi del Foro Boario. E ancora, fuori Roma: l’Arena di Verona, l’Arco di Augusto a Rimini e quello di Traiano a Benevento... Solo per fare alcuni esempi. Ma quanti sono i monumenti e gli edifici romani sopravvissuti in elevato fino ai nostri giorni in Italia? Non pochi, d’accordo. Nessuno li ha mai contati tutti, ma direi alcune decine, forse poche centinaia. E i monumenti medievali? Non c’è paragone, e di certo non si possono elencare uno per uno: palazzi, cattedrali, pievi, parrocchie, castelli, torri, mura urbane, monasteri, case... Qui parliamo in termini di migliaia di elementi, senza alcun dubbio. Il confronto è schiacciante: il Medioevo costruito vanta una percentuale di sopravvivenza altissima, a distanza di secoli. Non sorprende, quindi, che gli archeologi medievisti abbiano cercato fin da molto presto di attrezzarsi per affrontare questa enorme mole di dati, decodificarla e comprenderla in base ai loro metodi. È nata così, l’archeologia dell’architettura.
Gli scopi principali dell’archeologia dell’architettura sono due: da un lato, accrescere le conoscenze nel campo dell’industria edilizia e delle sue tecniche; dall’altro, rendere possibile la salvaguardia e un restauro “intelligente” dei singoli monumenti. Alla base di questo secondo punto c’è una considerazione di carattere generale, già compresa nel corso del XIX secolo: difficilmente un monumento che giunge in piedi fino ai nostri giorni si trova nelle condizioni originarie. Secoli di storia, di crolli e risarcimenti, di interventi di manutenzione, restauri e ristrutturazioni, lo avranno modificato, più o meno sensibilmente. Il monumento come lo vediamo oggi è perciò la somma di tutti quegli interventi: un vero e proprio palinsesto, che porta su di sé, ben visibili, le tracce di una lunga vicenda costruttiva.
Nel passato, alcuni architetti hanno optato per una scelta drastica: qualora un edificio dovesse essere restaurato, si sceglieva una fase giudicata più importante (poteva essere la più antica, o quella legata al periodo di maggior splendore del luogo e del complesso), e il restauro riconduceva tutto il monumento a quella fase (è quanto teorizzato da Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc [1814-1879] al culmine della sua carriera di architetto-restauratore). In questo modo si attuava una selezione nei confronti del passato, e l’edificio veniva praticamente bloccato in un fermo-immagine: ma chi ci dà il diritto di stabilire il momento “migliore” al quale ridurre un monumento che invece, come un archivio, contiene nelle sue strutture molte informazioni su secoli di storia? E come si seleziona, questo momento “migliore”, se non in modo arbitrario, e a scapito di tutti gli altri? Oggi la pensiamo diversamente: ogni fase attraversata da un edificio ha la sua importanza storica, e l’archeologia dell’architettura è la disciplina che permette di indagare e comprendere tutte le trasformazioni di un monumento, dalle sue origini fino ad ora. Grazie ad essa è possibile ricostruirne una storia completa, senza esclusione di alcuna fase; e indirizzare il restauro in modo che permetta di visualizzare le varie fasi, senza azzerarle per raggiungere una
scaricare
Questo sito non memorizza alcun file sul suo server. Abbiamo solo indice e link contenuto fornito da altri siti. Contatta i fornitori di contenuti per rimuovere eventuali contenuti di copyright e inviaci un'email. Cancelleremo immediatamente i collegamenti o il contenuto pertinenti.
| Comunicazione e giornalismo | Diritto |
| Economia, affari e finanza | Educazione |
| Informatica | Ingegneria |
| Medicina e scienze sanitarie | Scienze e matematica |
| Scienze sociali | Umanistica |
Il ponte sulla Drina by Ivo Andric(3628)
Il cazzaro verde by Andrea Scanzi(3146)
La Storia by Elsa Morante(2844)
Accabadora by Michela Murgia(2581)
Le otto montagne by Paolo Cognetti(2572)
Erewhon by Samuel Butler(2433)
Afrodita by Isabel Allende(2368)
Pastorale americana by Philip Roth(2175)
Shantaram by Gregory David Roberts(1965)
Americanah by Chimamanda Ngozi Adichie(1940)
La montagna incantata by Thomas Mann(1912)
Lo Hobbit (illustrato) by John Ronald Reuel Tolkien(1664)
The help by Kathryn Stockett(1572)
Come cavalli che dormono in piedi by Paolo Rumiz(1569)
Demian by Hermann Hesse(1530)
L'eroe dai mille volti by Joseph Campbell(1480)
Una variazione di Kafka by Adriano Sofri(1437)
Factfulness by Hans Rosling(1427)
Breve storia del mondo by Ernst Gombrich(1390)
